Ripensare Herbert Marcuse nel XXI secolo. di A. Angeli
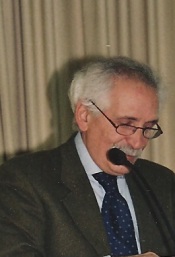
Il 29 giugno 1979 muore Herbert Marcuse Sono quindi trascorsi 40 anni dalla sua morte e 55 dalla pubblicazione del saggio: “L’uomo a una dimensione” uscito nel 1964,( Torino, Einaudi 1967). “Una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non libertà prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico”. Con questa frase significativa inizia la lucida analisi di Herbert Marcuse della società nella quale viviamo, in perenne “bilico tra la pace e la guerra: la società industriale avanzata diventa più ricca, più grande e migliore mano a mano che aumenta il pericolo”. Riguardo a questa società, continua l’autore: ”La sfiducia nella politica è sempre più diffusa e si manifesta nell’allarmante crescita di assenteismo alle urne, nonché dall’emergere di figure carismatiche capaci di convincere gli elettori in virtù di un utilizzo retorico del linguaggio e delle informazioni”, (idem), Del resto Marcuse aveva già denunciato il carattere sempre più ipocrita del sistema elettorale: “Il processo elettorale è da tempo dominato dal potere del denaro, e la separazione dei poteri si è trasformata in una dittatura presidenziale. La distinzione tra la carica e chi la detiene, una delle conquiste più rilevanti della civiltà occidentale nel cammino verso la libertà, ormai al collasso”.( idem). La società contemporanea è presentata come una democrazia bloccata, che vede il sistema chiamato democratico impegnato a ricomporre il conflitto, le istanze contrarie allo stesso sistema: “asservendo il pensiero critico al consumo, stroncando ogni istanza conoscitiva con i vecchi e nuovi mass-media” ( idem ).
“E’ un ordine sociale che appare totalitario”, quello considerato da Marcuse:, “che permea di sé ogni aspetto della vita dell’individuo e, soprattutto, che ha inglobato anche forze tradizionalmente ‘anti-sistema’ come la classe operaia. In questo modello la vita dell’individuo si riduce al bisogno atavico di produrre e consumare, senza possibilità di resistenza. Marcuse denuncia il carattere fondamentalmente repressivo dalla società industriale avanzata. In queste brevi annotazioni del saggio: L’Uomo a una dimensione, si coglie un Marcuse più pessimista rispetto ad Eros e Civiltà, meno disponibile ad arrendersi ad una società tecnologica avanzata che riduce tutto a sé, ogni dimensione ‘altra’ è asservita al potere capitalistico e ai consumi, conquistata dal dominio ‘democratico’ della civiltà industriale; una società che condiziona i veri bisogni umani, sostituendoli con altri artificiali. È in questo senso che Marcuse formula la condanna della tecnologia, che conterrebbe già insita nella sua natura un’ideologia di dominio. Ma esistono ancora dimensioni al di fuori di esso, “al di sotto della base popolare conservatrice”? Marcuse risponde affermativamente: “vanno ricercate negli emarginati, nei reietti, nei perseguitati, nei disoccupati, in coloro cioè, che non sono ancora stati fagocitati dalla società repressiva”.
Marcuse è stato uno dei pensatori più influenti del XX secolo ed il suo pensiero è stato l’humus della rivolta studentesca, che fin dagli inizi degli anni 60 coinvolse numerose Università americane, per dilagare nell’Europa: Francia, Germania, Italia, Olanda, Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Danimarca, milioni di giovani che occuparono Università ed intere città, con il loro messaggi di libertà, eguaglianza, pace, fratellanza. E fu appunto il suo pensiero, marxianamente anti-autoritario, ad offrire una lucida analisi teorica alla volontà di cambiamento radicale che animava la protesta dei giovani in tutto il mondo occidentale; assoluto e concreto il suo rifiuto di ogni forma di repressione accompagnato da una decisa contrarietà alla civiltà tecnologica, comunque considerata secondo le declinazioni liberal-capitalistica e comunista-sovietica. E tuttavia, egli può essere definito un pensatore marxista critico anche se spesso si si trovò in contrasto con le correnti di pensiero che si raccoglievano attorno alla cosiddetta scuola di Francoforte. Ciò nonostante, di fronte al fallimento, durante il XX secolo, delle esperienze politiche e di governo che si rifacevano a Marx, e al dissolversi dello scontro di classe in occidente, comprese che la lotta non era finita. Nuove realtà si affacciavano sul terreno della lotta di classe, che egli individuò nel terzo mondo, oppresso dall’imperialismo occidentale e dalle nuove forme di sfruttamento delle ricche risorse di quei Paesi. La sua analisi concludeva nel rilevare come le linee del fallimento della lotta di classe in occidente, avessero facilitato e aggravato la resa con cui le classi emarginate del “primo mondo” si erano sottomesse alla nuova oppressione imperialista pur di poter partecipare, accontentandosi, alla distribuzione delle briciole del banchetto capitalista.
Marcuse è stato l’autore di un pensiero originale e complesso e forse per questa sua difficoltà, intorno ad esso, si è consumata una classica reduction ad absurdum, quindi una chiusura ad ogni approfondimento sociologico e considerazione filosofica, a cui ha concorso un succedersi di avvenimenti dagli anni 80-90 fino alle soglie del 2000, con il venir meno delle chanches rivoluzionarie con l’avvento del capitalismo globalizzato e la distruzione delle forze politiche apertamente anti-capitaliste ( sulle quali peraltro, come si evince dai suoi scritti, non aveva fatto troppo affidamento ). Oggi, al secondo decennio dl XXI secolo, si può essere indotti a pensare che il lavoro teorico del filosofo tedesco sia ormai inevitabilmente datato, in quanto espressione di un tempo storico che non si riteneva possibile si sarebbe riproposto. Certamente, per molti intellettuali e sociologi del momento, è meglio concentrarsi su altre tradizioni di pensiero, dal liberalismo finanziario e sovranista ai proclamati sostenitori del postmodernismo. E’ necessario essere chiari: per recuperare il pensiero di Marcuse, conviene guardare avanti, superare l’ideologia che sostiene il capitalismo neoliberista e lo appalesa come unico orizzonte dell’esistenza dell’uomo. Di Marcuse è necessario recuperare quei filoni nascosti del pensiero del ‘900 che possono servirci per spiegarci politicamente il presente, per dare ragione della nostra stessa condizione storica e di come uscirne.
Alberto Angeli
